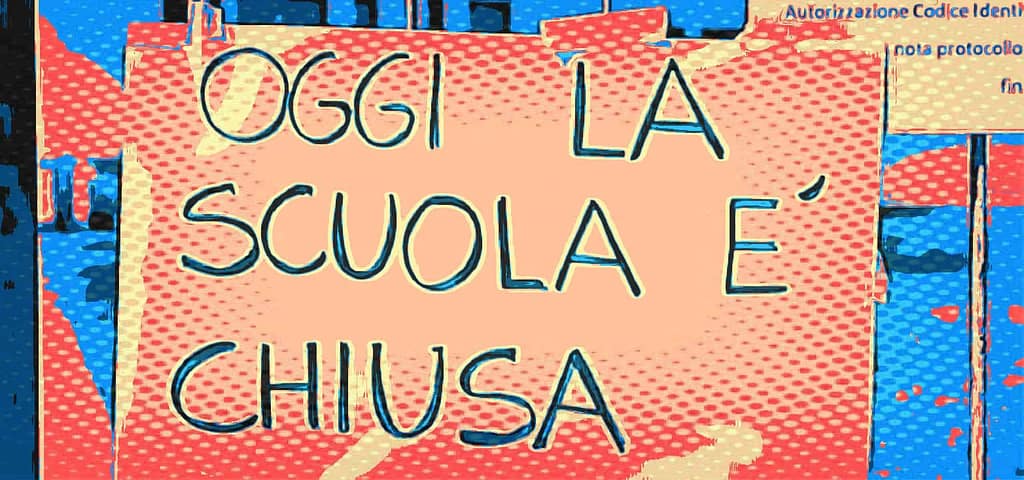Condividendo il contenuto di questo articolo di Prospettiva Operaia, lo ripubblichiamo
A poche settimane dalla data indicata per la riapertura generalizzata delle scuole è ripresa forte la pressione di governo e padronato.
È nella scorsa estate che prende corpo il mito della scuola “sicura”. Da un lato, vengono sistematicamente ignorate le uniche misure che veramente avrebbero potuto garantire livelli minimi di salute – e socialità – nelle scuole e come tali rivendicate dalle reti sociali più attente e sensibili: aumento degli spazi e del personale, potenziamento del trasporto pubblico e, sullo sfondo, della sanità di prossimità. In questo quadro, i cosiddetti “protocolli di sicurezza”, concordati da governo, cts, padronato e sindacato, sono chiamati a ‘mimare’ sicurezza senza un investimento di risorse reale – cioè in grado di produrre cambiamenti strutturali. Perciò il distanziamento si riduce da due metri, prima a un metro, poi al famoso metro tra “le rime buccali” – metro teorico, sulla carta, metro che non c’è. Nello stesso uso delle mascherine si manifesta una certa insofferenza, si prevedono le eccezioni più varie. Insomma: le scuole devono aprire e perciò sono dichiarate sicure. Contemporaneamente, viene avviata una violenta campagna portata avanti sulla stampa mainstream, quella sensibile agli interessi degli industriali e della loro punta più aggressiva, l’Assolombarda, corresponsabile della strage padronale e di Stato in Lombardia lo scorso marzo-aprile. Il tutto con l’avallo della Fondazione Agnelli e della Associazione Nazionale Presidi, da sempre ‘vicina’ agli stessi interessi economici (che però al tempo stesso mette le mani avanti chiedendo lo scudo penale a fronte della responsabilità per eventuali contagi).
L’obiettivo è chiaro: imporre una ‘normalizzazione’ del rischio per la salute, invece di investire risorse per contenerlo e contrastarlo: scaricare, anche in questo settore, sui lavoratori il pericolo di contagio, così come, da marzo in poi, è avvenuto sia nelle fabbriche, sia nel settore pubblico, a partire dalla sanità (ospedali e ambulatori medici). Si tratta di vera e propria lotta di classe dal versante del padrone, volta a intimidire e soprattutto imporre il silenzio ai lavoratori della scuola, agitando, come di consueto, gli interessi degli ‘utenti’ e consumatori – in questo caso dell’istruzione.
Sin dall’estate è evidente che l’apertura delle scuole diventa l’assicurazione, ideologica e pratica, contro ciò che il padronato teme di più, un nuovo lockdown, la garanzia che i luoghi della produzione e del profitto continueranno a rimanere aperti, la prova provata che col virus ‘si può – e in nome dei profitti si deve – convivere’. L’azionista di maggioranza della rivendicazione delle “scuole aperte” è e rimane Confindustria.
A settembre, la favola della “scuola sicura” viene rilanciata dai centri del potere economico e politico – nonché culturale – di questo paese, a partire dal ministero dell’istruzione, che infatti a poche settimane dall’inizio (frammentario) della scuola diffonde dati rassicuranti: è la scuola nella quale “non ci si contagia”, giacché, al limite, il contagio “viene da fuori”. Nel frattempo, già ad ottobre, proprio dai luoghi dove le scuole sono rimaste aperte più a lungo, i lavoratori raccontano una storia diversa: tamponi negati, contatti non tracciati, casi sommersi da protocolli locali delle asl con la compiacenza delle dirigenze. Nelle scuole superiori, ai lavoratori i cui colleghi sono risultati positivi, viene imposto di continuare a lavorare, senza tampone e senza quarantena. Oggi sappiamo ciò che era sotto gli occhi di tutti: che il ministero intenzionalmente ha ostacolato il tracciamento e il reperimento dei dati, e anche di quelli suo malgrado raccolti impediva la pubblicazione e la stessa trasmissione al cts. Sappiamo dunque che i protocolli si sono rivelati largamente insufficienti e hanno offerto l’alibi col quale esporre al contagio migliaia di lavoratori (i cui numeri reali sono tenuti del resto riservati, come i numeri dei contagi sui luoghi di lavoro in generale). Da qui l’avvicendarsi delle chiusure e delle quarantene – di quelle ‘concesse’ e di quelle negate. Da qui anche le diverse condizioni di apertura o chiusura delle scuole imposte dalle regioni: lì dove le pressioni padronali sono più forti (vedi la Lombardia e il Piemonte) si impone l’apertura ‘senza se e senza ma’, con la didattica in presenza (ma anche col drastico aumento dei contagi di lavoratori e studenti); lì dove invece (a partire dalla Campania), a fronte di un tessuto socio-economico più fragile, preoccupa la tenuta del sistema sanitario, le scuole chiudono, o meglio, passano alla didattica a distanza (dad). Le misure – le une e le altre –, nei diversi contesti economici e sanitari, sono volte a garantire in ogni caso la tenuta del sistema basato sulla produzione e sui profitti.
Intanto monta la protesta “no dad”. Già durante l’estate, realtà di genitori, i settori del sindacalismo di base presenti nella scuola, ‘intellettuali’, si mettono insieme, non senza ambiguità: ché se da una parte si rivendicano misure vere per garantire la salute a scuola nelle nuove condizioni della pandemia – quelle sopra menzionate, a partire dall’aumento di spazi e personale, tracciamento, tamponi gratuiti –, dall’altro si fa più forte il tam tam a favore di un indiscriminato “scuole aperte”.
A settembre l’ambiguità si scoglie: a fronte delle rivendicazioni ignorate, di una scuola dunque più “insicura” che mai – da parte di queste realtà la richiesta delle scuole aperte “senza se e senza ma” è assordante. E se la protesta ha una proiezione nazionale, riconoscendosi nella rete “Priorità alla scuola” (Pas), la Campania, proprio perché le scuole sono state chiuse più che altrove, diventa un laboratorio importante.
Qui le aree più aggressive – quelle che si riconoscono nel gruppo facebook “Fuori dagli schermi”, ma anche ampi settori di Pas – insistono esplicitamente su questa rivendicazione: nelle loro assemblee (ma anche sul giornale online radical chic “Napoli Monitor”) la parola “sicurezza”, ma anche quella “salute”, diventano tabù; sono quelli che negano che le scuole siano da considerare luoghi di lavoro, giacché si tratterebbe piuttosto di ‘servizi’ da garantire, i cui lavoratori sono condannati all’invisibilità, a diventare trasparenti. In generale, in questi ambienti si respira la vecchia ostilità per il lavoro del settore pubblico, il risentimento nutrito dei pregiudizi circa supposti privilegi, la vecchia retorica reazionaria alimentata dagli ambienti padronali contro i “fannulloni”, ripulita (ma neanche più di tanto) e ripresentata sotto le spoglie del “diritto all’istruzione” da garantire ad ogni costo (e a spese di altri). Nella migliore delle ipotesi è guerra tra poveri. Insomma, è il vecchio grido del padrone “Tornate a lavorare!” che risuona in queste assemblee, senza che nessuno ne metta in discussione la legittimità. Nell’indifferenza – o anche l’ostilità – che i comitati per la scuola aperta “senza sé e senza ma” esprimono per qualunque esigenza sia legata alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola c’è poi dell’altro: un mix di fatalismo e individualismo (il contagio non mi riguarda – o, anche, non esiste – finché non mi tocca direttamente), e forse anche noncuranza di una generazione, quella più giovane (dei genitori), verso quella un po’ più anziana e che rischia di più (cui appartengono molti insegnanti e collaboratori).
Lungi dal chiamare in causa il ministero e i suoi referenti economici e politici, queste aree rivendicano ‘diritti’ ed ‘emancipazione’, e intanto passano da una prima pagina all’altra dei quotidiani padronali, i quali oggi continuano sistematicamente ad amplificare le proteste per l’apertura delle scuole “senza se e senza ma”, celebrando una “piazza” che in verità non c’è perché non trova vero consenso, in cui i pochi partecipanti si auto-erigono a rappresentanti della comunità scolastica (del resto basta dare uno sguardo agli editorialisti che nelle ultime settimane si sono spesi in tal senso su Repubblica e Corriere: De Bortoli, Boeri, Galli della Loggia, solo per fare alcuni nomi: tecnocrati, uomini di Stato, consueti protagonisti di una propaganda nazionalista e autoritaria).
Di contro, le storie dei contagiati e anche dei morti della scuola rimangono distanti dalle prime pagine regalate ai “no dad”, le loro voci sommerse da un coro al quale hanno preso parte per troppo tempo in troppi.
La scuola si rivela in ciò luogo di lavoro come tanti: luoghi della mancanza di salute, della sicurezza mancata. Tanto più colpisce, in questo quadro, l’atteggiamento del sindacalismo di base partecipe della protesta (Confederazione Cobas e USB). Anche qui, un po’ come in tutte le sue ‘anime’, qualunque voce si neghi al coro che chiede l’apertura/riapertura, o la stessa distanza della gran parte dei lavoratori da queste rivendicazioni, sono ricondotte a un irrazionale “aver paura”: l’esigenza della salute è scaricata così sul privato del singolo e del suo vissuto – con un meccanismo che i potenti di questa società praticano quotidianamente, e che ora fa la sua comparsa nel mezzo della retorica del ‘prendere parola’.
Sin dall’inizio, in questi settori sindacali, l’avversione alla dad oscura la rivendicazione di misure di sicurezza come condizione per l’apertura delle scuole – condizione che si evita accuratamente di formulare. Appaiono preoccupati più della possibilità che la famigerata “didattica a distanza” divenga la normalità, con la connessa possibilità di precarizzazione e crescita dello sfruttamento.
Ora, è vero che la spinta alla digitalizzazione costituisce una delle direttrici della razionalizzazione neocapitalistica della didattica ai giorni nostri. Se ne fraintende però il senso se la si intende come spinta alla sostituzione della didattica in presenza con quella a distanza. Perché la digitalizzazione nel segno del capitale proceda, e possa essere un buon affare per le imprese, è necessaria proprio la scuola in presenza – una scuola in presenza a ogni costo, nella quale proceda tutto ‘come prima’ e nella quale possa proseguire la spinta all’uso delle nuove tecnologie secondo l’interesse delle imprese. L’impresa è interessata a invadere e occupare lo spazio scolastico, non a lasciarlo vuoto (si veda infatti la famigerata “Alternanza scuola-lavoro”, e oggi PCTO, tutti, malgrado i desiderata del ministero, più o meno interrotti o rimasti sulla carta a causa dell’emergenza sanitaria).
In questa contingenza, la responsabilità delle élite del sindacalismo di base (come anche di Potere al Popolo, che dopo un’evidente politica di attesa, nel segno del consueto tatticismo, ha rotto gli indugi schierandosi con l’anima più aggressiva dei no-dad), è enorme: assecondando i peggiori impulsi della protesta, hanno negato ai lavoratori ‘indisponibili’ a seguirne le rivendicazioni ogni spazio e parola. Oggi (giustamente) si lamentano di fronte alle limitazioni che il governo, passando all’incasso, sta imponendo al diritto di sciopero nella scuola, considerato, appunto, come un “settore essenziale” – ma questa retorica del servizio essenziale dell’istruzione negli scorsi mesi l’hanno assecondata in tutti i modi.
Di fronte a questi abbagli, c’è da aspettarsi di più dalla distanza e dalla diffidenza con la quale i lavoratori della scuola assistono a questo ennesimo balletto sulle loro teste. Da qui, forse, a partire da gennaio, se verrà imposto un ritorno generalizzato nella medesima scuola di prima, e se dovesse aversi un aumento esponenziale dei contagi, potrà levarsi un rifiuto del lavoro senza sicurezza.
Nei momenti di crisi i privilegiati, mentre riversavano su lavoratori, precari e disoccupati, austerity e tagli a reddito e diritti, hanno invocato l’unità nazionale all’insegna degli “interessi del paese” o dello “sviluppo”. Oggi lo fanno, tra l’altro, in nome dell’ “istruzione”.